


| Marco Montanari |
   |
| Gildaldo Bassi, fotografo (1852 - 1932) | |
| Gildaldo Bassi Fotografo (AGE, Reggio Emilia, 1994) |
"Amici [ ... ], nati in un paese dove il dispotismo antico ha lasciato assai più profondamente che altrove i suoi sinistri effetti [ ... ] ridotti tutti quanti a buscare giorno per giorno il pane alla ventura, ci siamo trovati divisi da gelosie di mestiere, da antiche personalità [ ... ] i ricchi si studiano di fare di noi operai come tanti accoliti, tanti servi devoti, intendendo di comprare col misero compenso al nostro lavoro anche il nostro pensiero, la nostra coscienza, di farci cieco istrumento della loro ambizione [ ... ] bisogna pensare a rialzarci, riuscire ad emanciparsi, farci forti [ ... ]. Parole intrise di retorica, ma il linguaggio politico è anche questo, parole che ci raccontano una battaglia, durata una vita, un'avventura umana rimasta a noi in un diario di immagini e pochi pensieri. Duplice aspetto che racchiude le "due anime" di Gildaldo Bassi: l'uomo-politico, protagonista di lotte operaie, non solo organizzatore e fautore del socialismo locale, ma coraggioso e deciso diffusore di tali ideologie e il pittore-fotografo, come amava definirsi, attento e realista testimone del microcosmo correggese attraverso immagini che sono rimaste per decenni l'unica iconografia della nostra città. Gli spiragli attraverso cui guardare direttamente nella sua vita sono pochi: circa duecento fotografie e un pugno di articoli. Molteplici gli aspetti che non hanno trovato una risposta adeguata nel lavoro di ricerca svolto intorno a questa figura, nodi che non impediscono di cogliere i tratti salienti del personaggio. Fughe, arresti, accuse: elementi che ne esaltano il coraggio e la caparbietà di portare alta un'idea, che trova riscontro tangibile nell'opera fotografica e che questo studio tende a mettere in luce. Un duplice percorso (politico/fotografico) in continua sinergia. Complesso, forse fortuito, l'approdo alla fotografia. Gildaldo Bassi ne apprese l'arte in Sud America. Difficile essere più dettagliati, nessuna fonte ci viene in aiuto, possiamo soltanto fare alcuni passi indietro e ricostruire i primi vent'anni di vita dell'artista per rendere plausibile questo lungo viaggio. Gildaldo-Medardo detto Paolo nasce a Mandrio di Correggio nella casa dei nonni materni il 1° maggio del 1852 2 , notizie sulla sua adolescenza ci vengono da un breve articolo-biografia del dopoguerra in cui "Spartacus", questo lo pseudonimo che l'autore usa, riscrive l'atmosfera di quegli anni: "dai genitori - narra - traspirò lo spirito patriottico del Risorgimento ed aveva sette anni quando si trovava fra la folla che riunita in Piazza delle Erbe, applaudì Garibaldi che si affacciava da una finestra dell'albergo Posta. Le immagini ed i ricordi delle imprese delle camicie rosse, i fatti tristi, ma gloriosi di Aspromonte e Mentana ed infine l'ultimo atto del Risorgimento, l'occupazione di Roma palatina, infervorarono la fantasia del giovane di umili origini e scavarono delle tracce profonde nel suo animo" .3
Biografo non disinteressato, "Spartacus", nel tentativo di legittimare uno dei personaggi legati al periodo arcaico ed eroico del socialismo, ci aiuta a cogliere quello che poteva essere l'entroterra culturale in cui si formò il fotografo, "una singolare figura - continua - che ancora vive nel cuore dei più anziani, una personalità ricca di fascino. A diciannove anni, avvicinatosi alle frange più estreme dei socialisti e degli anarchici aderì a una società operaia, nel 1872 partecipò allo storico Congresso delle Società Operaie di Rimini, dove conobbe il segretario dell'assise, personaggio in cui si identificò un periodo del movimento socialista italiano: Andrea Costa. I due si conobbero, condividendo un comune destino di ideali e future persecuzioni e sofferenze". Quest'ultime ben presto si concretizzano, Gildaldo viene arrestato per propaganda sovversiva ben due volte nel 1873 e costretto dalle continue persecuzioni della polizia a emigrare nell'America del Sud .4 Quattro anni avvolti nel mistero, nei quali apprese a fotografare, non sappiamo come, né da chi, certa è solo la data del suo ritorno a Correggio nel maggio del 1878 .5
"Gildaldo Bassi fotografo in Correggio tornato dall'America" scriveva sul retro delle "carte de visite", pubblicizzando il suo atelier. Sono questi gli anni in cui grande è lo sforzo dell'artista di avviare l'attività, giungendo subito a concreti risultati; non bisogna altresì dimenticare l'impegno politico, questo tumultuoso giovane obbligato dalla polizia ad un'emigrazione forzata non ha rinunciato alla sua "battaglia", diventata ora meno radicale, ma ugualmente ricca di episodi. L'esordio in fotografia è da itinerante, una figura che si era andata diffondendo tra gli anni '50 e '60 soprattutto nel Nord Italia grazie a diversi dagherrotipisti molti dei quali stranieri, francesi in particolare; questi pubblicizzando il loro arrivo sulle gazzette locali, facevano sosta in molte città diffondendo anche il mestiere. La dagherrotipia negli anni in cui Gildaldo Bassi diviene fotografo itinerante è ormai scomparsa, invece è ampiamente diffusa la tecnica al collodio. Con la sigla "Fotografia Viaggiante" ben impressa sulle fiancate di un pittoresco carrozzone, si spostava di paese in paese limitandosi, sembra, ai dintorni di Correggio, animando mercati e fiere; un vero e proprio atelier mobile, completo di tutto il necessario per un ritratto alla moda o un'economica "carte de visite". Il maggior impulso all'attività venne con l'uscita della prima serie di vedute correggesi (agosto 1879), trenta immagini per la precisione, vendute al prezzo di 37,50 lire al Comune di Correggio, a cui l'anno seguente se ne aggiunsero altre dieci. Un'operazione questa che ha permesso molta della passata e presente fortuna dell'artista .6 La serie rappresenta nel suo complesso un documento importantissimo, un valore, che viene ampiamente confermato dal recente "censimento" che ha permesso l'individuazione in ben quindici collezioni private, qualcosa come circa trecento fotografie. Rimandando ad altro momento considerazioni più ampie ed articolate e continuando a illustrare gli esordi del Bassi nella fotografia, di notevole interesse risulta uno dei primi riconoscimenti pubblici che ricevette. Il Caporale di Settimana, periodico correggese di stampo borghese, nell'ambito del numero dedicato all'inaugurazione del monumento di Antonio Allegri, trova un piccolo spazio per elogiarlo: "il Bassi si fa veramente onore colle sue fotografie. Abbiamo visto quelle del Monumento al Correggio e le altre molte che esso ha preparato per l'inaugurazione. Sono tutte veramente belle e rendono testimonianza dell'abilità non comune del giovane fotografo.7
Un elogio condivisibile, infatti il fotografo toccò con questa serie l'apice della sua arte, non riuscendo, in episodi simili documentati, a ripetersi. In questa occasione mostrò buona capacità imprenditoriale, sfruttando senza esitazioni un importante avvenimento come l'inaugurazione del monumento al Correggio, episodio di storia locale molto sentito dai cittadini in cui il Comune si espose a un notevole sforzo economico. Tante le fotografie del monumento dei personaggi ad esso collegati; si pensa, inoltre, che abbia collaborato con lo scultore Vincenzo Vela, inviandogli le fotografie delle piazze correggesi per meglio collocare la statua. Due anni dopo nel giugno del 1882, apre il primo atelier. E' di nuovo il Caporale di Settimana che ne pubblicizza l'apertura: "ci viene riferito che il sig. Bassi Gildaldo, che modestamente non vuole che essere un dilettante dell'arte fotografica, in una terrazza elegantemente disposta e coperta di cristalli nella casa di sua proprietà in piazza delle Erbe ha impiantato un ordinatissimo laboratorio fotografico con tutte le più recenti innovazioni dell'arte [ ... ] invitiamo i nostri concittadini a servirsi del Bassi, sicuri come siamo, che saranno soddisfatti con precisione e modicità dei prezzi".8
Atelier che diventerà presto punto di incontro di chi, come lui' porterà avanti lotte politiche e sociali.
Se' in questi primi anni dopo il ritorno dall'America, il Bassi è stato intensamente impegnato nel costruire una fiorente attività, non tardò da quel momento in poi a battersi per il nascente schieramento socialista. Il decennio tra il 1880 e il 1890 fu di grande fermento; organizzò molte adunanze pubbliche, non solo nel territorio correggese, ma anche in altre piccole città, quali Massalombarda e Borgo San Donnino (attuale Fidenza) sedi di importanti Società Operaie9' diffuse programmi di realizzazione sociale come quello del professor Ruggiero Panebianco (Abiezione e martiri, ossia effetto dell'appropriazione esclusiva della terra)" e fu acceso accusatore di palesi iniquità. Un episodio in particolare fu ampiamente riportato dalle cronache del tempo: un vivace botta e risposta tra il Bassi e un medico accusato di discriminare le sue cure in base alla classe sociale dell'ammalato.11 Dalle pagine della Giustizia' giornale socialista di cui fu un occasionale collaboratore' si scagliò senza remore contro la classe dirigente "sempre paga del triste egoistico e instabile oggi' perché nella sua ogni veggenza non giunge a comprendere il grande, generale e ognor crescente benessere del domani." Il pretesto dell'invettiva è la biblioteca comunale' popolare solo in apparenza; con grande intraprendenza si improvvisò bibliotecario offrendo in prestito libri, invitando i correggesi inter ed extra murso [ ... ] i poveri laboriosi ed avviliti operai ... ] a leggere e meditare pel loro e pel comune interesse." Motivo di tanta propaganda, l'uscita del libro di Bellamy (L'avvenire Uno sguardo retrospettivo dall'anno 2000 ai giorni nostri.) che propone "una graduale e persuasiva riforma dell'attuale barbara e corrotta SoCietà."12 Se possiamo immaginare, alla luce dei documenti rinvenuti' che l'atelier del fotografo correggese fosse ben avviato nel mercato delle "carte de visite"' non possiamo escludere anche una qualche conseguenza negativa' che il continuo esporsi in prima persona in dispute sociali e politiche' ebbe sul suo lavoro. E' di questi anni la richiesta al Comune di Carpi per un album fotografico simile alla fortunata serie degli anni ottanta' ma la proposta del fotografo venne rifiutata. Tra il 1885 e il 1890 il Bassi scattò alcune immagini a carattere religioso, che documentano la collaborazione tra il nostro e l'ingegnere carpigiano Achille Sammarini; una piccola serie che pur partendo da un'impostazione simile alle precedenti raggiunge risultati di gran lunga inferiori. Qualche anno più tardi, nel 1892, un nuovo impegno per Gildaldo' che diviene responsabile del giornale La Fiaccola' organo ufficiale dei socialisti correggesi13; la posizione di primo piano' nel panorama politico locale, non sfuggì alla pubblica sicurezza che' nel timore che gli impeti rivoluzionari giovanili si fossero risvegliati, controllò a vista il fotografo per un lungo periodo. Ne derivarono continue perquisizioni' la più eclatante delle quali fu riportata nelle pagine di cronaca della Giustizia. Il cronista racconta che nell'aprile di quell'anno, la pubblica sicurezza irruppe nella casa-atelier di primissimo mattino, con la convinzione di trovarvi un arsenale di materiale esplodente e armi. "Naturalmente - scrive con ironia e soddisfazione - il tutto si rivelò un assoluto fiasco."" In quello stesso anno il Bassi vive un passaggio fondamentale per il Partito Socialista partecipando allo storico congresso di Genova assieme a Camillo Prampolini' uno dei padri fondatori del nascente partito, di cui era amico; in quei giorni aderì al marxismo. L'anno seguente' durante il congresso di Reggio Emilia documentò l'avvenimento con due immagini' una delle quali scattata al banchetto di Massenzatico. "Prezzo di ciascuna fotografia L. 2, per le due fotografie insieme L. 3" recitava l'avviso pubblicitario apparso sulla Giustizia. 15
Il 1898 segna una svolta significando idealmente la fine di un percorso in ascesa per Gildaldo Bassi, anche se i fatti accaduti in quell'anno, indicherebbero il contrario; assistiamo infatti a un ulteriore impulso dell'attività: l'apertura di un grande atelier fotografico a Reggio Emilia in piazza Cavour n. 3 che si andava così ad aggiungere a quello correggese. E' plausibile giustificare un investimento simile con motivazioni di varia natura; in primo luogo, visto il grande fermento politico di quegli anni, questo rappresentava una scelta di campo precisa. Reggio Emilia infatti significava una maggior partecipazione alla vita politica e una maggior vicinanza al leader del movimento Prampolini' a cui scattò alcuni ritratti singoli o con la famiglia in quadri "en plein air". Una scelta così importante non può non implicare anche precisi intenti di carattere economico-commerciale' uno studio nell'importante "piazza" di Reggio è tutt'altra cosa rispetto a un atelier di provincia. Significativo in questo senso, l'utilizzo di "cartoncini" per piccoli ritratti con il marchio "Fotografia civile e militare", da cui traspare chiaro l'intento di cercare di conquistare la più ampia clientela' in questo caso specifico' i molti militari della vicina Caserma Zucchi.
Altri stravolgimenti mutarono però repentinamente i progetti del fotografo: erano quelli' anni politicamente "caldi". Già dal 1897 il malcontento per la politica crispina esplose con violenza, vaste erano state le agitazioni contro il carovita e l'anno seguente in molte città esplose la rabbia del popolo; dura la risposta del governo' che a Milano, per mano del generale Bava Beccaris' sparò cannonate sulla folla. Bassi insieme ad altri socialisti reggiani partecipò alla sommossa e venne arrestato per la terza volta e trattenuto nel carcere di Finalborgo per alcune settimane." Queste tormentate lotte politiche' che lo coinvolsero come protagonista, assestarono un duro colpo alla sua attività commerciale. Nel 1900 chiude lo studio correggese 18 ' due anni dopo cessa completamente di lavorare cedendo lo studio !-eggiano'9' una decisione improvvisa difficile da giustificare con riscontri plausibili, considerando che nel 1901 aveva chiesto e ottenuto di poter ampliare l'atelier. Di questo periodo ci rimangono alcune belle immagini, un comizio, l'inaugurazione di una cooperativa, gesti di una autentica passione politica. Poche luci sugli ultimi trent'anni di vita. "L'irrequietezza e la smania di viaggiare non lo abbandonarono mai" scrive il cronista di Reggio Democratica, ma questi continui spostamenti li possiamo anche identificare come fughe dal regime che in lui vedeva un personaggio ostile. Tra il 1907 e il 1916 è a Mestre poi a Venezia sembra "per desiderio di luce e sole"."
Dopo cinque anni dal suo ritorno a Correggio nel 1916, perse la moglie Domenica Bassoli, cucitrice, che aveva sposato nel lontano '82. "Cadono le ombre della vecchiezza per il cospiratore di altri tempi e nell'ora del tramonto è costretto, per sottrarsi alla violenza fascista, a riparare a Gavirate di Varese" (tra il maggio del 1924 e novembre 1931). Qui fu colto da paralisi. Torna a Correggio, dove muore il 19 marzo del 1932 .12 1 suoi funerali [ ... ] un commosso tributo in omaggio all'antifascismo correggese [ ... ] per un uomo che non sarà ricordato solo per l'attività politica [ ... ] ma chi si reca nella sala mostre della Biblioteca Civica avrà modo di ammirare- in un elegante album una serie di fotografie raffiguranti vedute del paese... preziosi documenti ancora nitidi e resistenti al tempo con un tono tuttora uniforme, dimostrando la perizia e la capacità di un uomo che mentre lavorava, viveva, sognava [ ... ].23
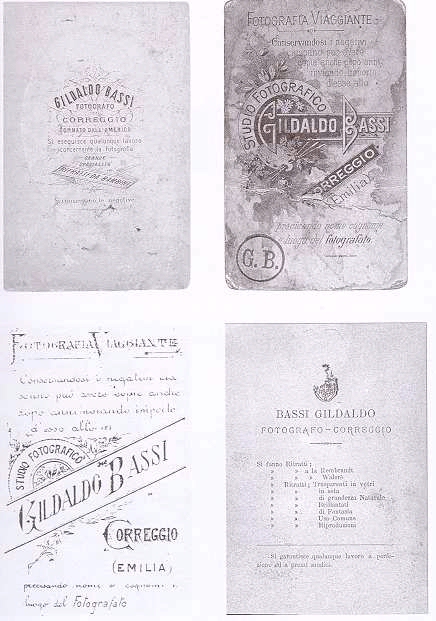 |
| Versi delle montature utilizzate dallo Studio Bassi dal 1879 al 1898 |
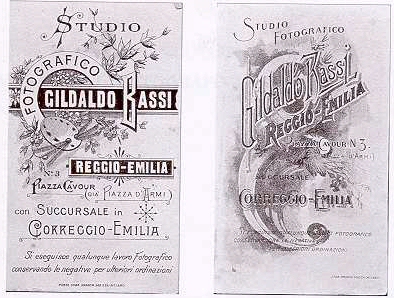 |
| Versi delle montature utilizzate dallo Studio Bassi dal 1998 al 1900 |
 |
| Versi delle montature utilizzate dallo Studio Bassi dal 1900 al 1902 |
Tra gli anni '50 e '60 dell'Ottocento assistiamo a un grosso impulso dell'industria fotografica sull'onda di alcune importanti scoperte, non ultima una nuova carta fotografica per stampe positive da negativo (A. Poitevin, 1856). Si apre così un primo importante processo di industrializzazione. Da questo momento in poi non sarà difficile reperire lastre negative o carta per stampa, facilitando in questo modo il lavoro del fotografo. Sono anni in cui l'immagine fotografica diviene patrimonio collettivo, una moda e un simbolo per gran parte della società. In questa situazione di generale fermento si collocano l'apertura dei primi importanti atelier a Reggio Emilia. Un punto di riferimento significativo è lo studio di Angelo Sorgato, importante esponente di una famiglia di fotografi padovani che avevano aperto nel nord Italia diversi atelier (Venezia, Bologna, Modena). L'attività, continuata poi con successo dal figlio Angelo Fortunato, era incentrata sul ritratto, di cui sperimentò nuove tecniche e su altre immagini di tipo architettonico. Ma tra i vari personaggi che animano la storia della fotografia reggiana, storia non dissimile da quella di altre città, è opportuno soffermarsi su due in particolare: Giuseppe Fantuzzi (Reggio Emilia 1859-1915) e Roberto Sevardi (Correggio 1865-Reggio Emilia 1940). Fantuzzi fu il più importante esponente della fotografia cittadina, ritrattista, ma anche testimone di importanti eventi sociali e politici. Autodidatta, iniziò il mestiere assai giovane; il suo primo studio era situato in via dell'Albergo (ora via Cairoli, n. 9) trasferendosi poi in via Emilia. Con lo stesso entusiasmo con cui si occupò di fotografia partecipò alla vita politica, (fu candidato nelle liste socialiste alle elezioni amministrative del 1904); amico di Prampolini e di Gaetano Chierici, il suo studio divenne una sorta di cenacolo di intellettuali e politici.'
Roberto Sevardi, correggese di origini, fu anch'egli autodidatta, iniziando per diletto a fotografare. Molte delle immagini che scattò nelle campagne e nei dintorni della città sono eseguite con un intento artistico, seguendo una cultura figurativa che fa riferimento a Chierici e a Cirillo Manicardi. Anche i ritratti eseguiti da Sevardi si distinguono per l'uso di criteri lontani dagli schemi professionali. ~ importante, inoltre, segnalare il suo impegno nel sociale di area cattolica' e i riconoscimenti a livello nazionale che riscosse con le sue fotografie.
Gildaldo Bassi rappresenta, alla luce di tutto questo, un capitolo importante, considerando che la sua attività prende vita dalla provincia; analizzando soprattutto la sua produzione si riscontrano molteplici fattori di distinzione, primo fra tutti le tipologie di immagini caratterizzanti la sua opera. Il Bassi spazia dal ritratto al paesaggio, da fotografie di impronta politica a riproduzioni di opere d'arte, dimostrando una notevole padronanza del mezzo. Spinto da richieste che coprivano ormai tutti gli strati sociali, trovando terreno fertile nei borghi rurali della provincia, intraprese il suo percorso come fotografo itinerante, mestiere che aveva sicuramente visto nel soggiorno americano. Una sigla alquanto esplicita "Fotografia Viaggiante", un grande carrozzone per trasportare gli arnesi del mestiere e tanta intraprendenza: questi gli ingredienti che gli permettono un veloce passaggio a un atelier stabile, come già ricordato nei capitoli precedenti. in questa fase, è necessario però, approfondire il discorso sulla sua produzione fotografica, in particolare considerare tutte quelle immagini legate al territorio, alla città, che rimangono, anche alla luce dei recenti ritrovamenti e attribuzioni, il momento più alto di tutta l'opera del correggese. Il riferimento è in particolare alla serie su Correggio, completata dalle raccolte su alcune chiese carpigiane e poche vedute del paese di Rio Saliceto. Risulta necessario, per un'analisi corretta partire dal gruppo di immagini più composito e omogeneo, quello sulla sua città natale, che, grazie anche al placet di giornali e istituzioni ha avuto grande fortuna. Le caratteristiche generali sono ormai ben note: un corpus di quarantuno vedute che realizzò in due tempi successivi, il primo intorno all'agosto del 1879 e il secondo nel giugno del 1880, immagini esposte durante l'inaugurazione del monumento di Antonio Allegri, registrando grandi consensi. La grande raccolta realizzata, presumibilmente, su lastre al collodio, oggi scomparse, e stampata su carta all'albumina, venne venduta in un formato inusuale, da lui stesso preparato. Per correttezza filologica bisogna segnalare anche la presenza di una serie più limitata, formato "carte de visite", coeva alla statua del Correggio, tutta incentrata sulla figura dell'artista.
Questa produzione affronta uno dei temi più ricorrenti della storia della fotografia di fine Ottocento: il vedutismo e la riproduzione di opere d'arte, generi che non si potevano sottrarre a regole stilistiche piuttosto rigide. 1 rigorosi princìpi che l'arte pittorica ha stabilito - scriveva Luigi Gioppi nel Dizionario Fotografico del 1892 - valgono certamente anche per la fotografia, tanto per il ritratto ed assai più per il paesaggio. Guai a chi nella composizione sacrificasse il principio unitario, a chi ponesse in vista più l'accessorio che il principale [ ... ]. E' evidente che il Gioppi per princìpi pittorici intenda parlare di prospettiva, simmetria, frontalità, proporzione fra le parti, regole queste attraverso cui la fotografia ha cercato, nel secolo scorso, una dignità artistica altrimenti negata; molto tempo dovrà passare ancora prima che riesca a liberarsi da questo pesante fardello. Nel segno di questi princìpi guida prende slancio la fotografia di paesaggio e d'architettura, che trova perfetti interpreti nel grande atelier degli Alinari. "Dettagliati nelle loro informazioni tinte di grigio, senza accenti di luce e d'ombre, da costringerci a ritenere a memoria ogni elemento dell'immagine, nessuna distrazione per lo sguardo, bloccato fra gli angoli del palazzo, del monumento, che si confronta impettito con il filo a piombo e il rettangolo del foglio su cui è impresso il suo fantasma, ritagliato dal contesto della strada che è vuota come dopo l'apocalisse, per quel poco che si intravede".' Questo breve ma illuminante quadro che italo Zannier ha tracciato della fotografia Alinari, ci permette di portare avanti un confronto e una verifica utili, pur nella sproporzione dei soggetti in causa, a mostrarci come un modello diffuso, di cui lo studio toscano fu in parte fautore, viene utilizzato con religiosa attenzione. La visione spesso frontale, a volte angolare, la ricerca di quinte spaziali nel tessuto architettonico, il punto di vista alto e un gioco di luci e ombre ben calibrato sono caratteri comuni, che lasciano poco spazio a confutazioni.
Accanto a molti punti di contatto con questo modo di lavorare, alcune le differenze che qualificano l'opera del Bassi. Una decontestualizzazione meno evidente, grazie all'inserimento di figure umane è l'elemento che balza agli occhi in maniera più evidente; un'impostazione simile trova un illustre rappresentante in Pietro Poppi, fotografo bolognese, che, come testimoniano alcune interessanti fotografie, visitò Correggio negli anni tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento'. L'immagine che l'occhio del Bassi coglie è fortemente mediata da un'ideologia radicata, quella stessa che lo fa essere costantemente in prima fila nelle lotte politiche di quegli anni: guardando le sue fotografie non possiamo tener conto di tutti questi fattori. Lo schema da lui seguito nello sviluppo del percorso di immagini paesane è di grande attualità tra i vedutisti ottocenteschi; le. immagini panoramiche diventano il punto di partenza per un'indagine più dettagliata dei tessuto urbano. L'apertura dell'album con una vista di grande respiro accompagnata dalle fotografie delle porte di ingresso del paese, crea una sorta di complicità tra architettura e gente del popolo ritratta quasi se ne voglia sottolineare la sovranità. Celebre in questo senso il "Piazzale dell'orologio" in cui un folto gruppo di correggesi, disposti dall'abile regia del fotografo, animano un quadro chiaramente simbolico. Il risultato però è spesso un insieme di comparse immobili, bloccate nella morsa di un'estenuante posa. Il "viaggio" prosegue attraverso scorci più anonimi del corso e di alcune importanti vie (Via Lunga, Via Casati, Piazza Castello), che sottolineano, attraverso l'uso di quinte scenografiche, ricavate dall'inquadratura delle abitazioni e dall'utilizzo di anonimi aiutanti, come la tendenza sistematica a isolare singoli elementi architettonici non sia l'unico criterio di rappresentazione utilizzato.
Gildaldo non solo ha saputo celebrare Correggio nei suoi fasti attraverso immagini dei piccoli gioielli del paese (Teatro, Palazzo Principi), ma anche denunciare con decisione e a più riprese il suo degrado: cortile del Palazzo Principi, via Casati, piazzale Munari, l'ospitaletto, esempi crudemente realistici dell'abbandono fisico in cui versava allora parte del centro storico. Sequenze che ci trasmettono il "colore", grazie all'uso sapiente della luce, scelta con attenzione nell'arco della giornata lasciando libertà alle ombre di tracciare i suoi pesanti disegni (Corso Cavour, Piazza S. Quirino). L'indubbia abilità tecnica è più evidente nel capitolo che l'artista dedica alle chiese; accanto alla fotografia della facciata, sempre estremamente "ripulita", ci viene mostrato l'interno con estrema dovizia di particolari, cosa non così semplice viste le condizioni di luce estreme e le difficoltà legate a una tecnologia non certo avanzata. Se il risultato è qui di ottimo livello, non certo la stessa cosa si può dire per la mini-serie delle chiese dei dintorni di Carpi, in particolare quelle di Limidi, di Cortile, di Migliarina. Le fotografie risalgono al 1887, tutte rigorosamente autografe e mostrano evidenti limiti nella ripresa. Forse l'impossibilità di porre la fotocamera in posizione sopraelevata, o forse difficoltà legate allo spazio circostante il soggetto hanno creato un effetto di convergenza delle linee verticali degli edifici piuttosto fastidioso. Trascorsi ormai sette anni dall'album correggese, Bassi collabora nei dintorni di Carpi con l'ingegnere Achille Sammarini 7 che è intervenuto in qualche modo su tutti gli edifici fotografati, ma purtroppo nell'eseguire le immagini incappa in errori da principiante. Per la serie riguardante Rio Saliceto, accanto a fotografie di edifici quali la scuola, il municipio, colti in completo isolamento, ve ne sono altre che di nuovo mettono in luce la capacità del Bassi nel disporre le persone, nel creare quadri "en plein air", questo trova un altro buon esempio in un'immagine correggese del Torrione, fotografia tarda scattata di ritorno da Venezia intorno al 1907.
Accanto a questa produzione, importante perché ricca di spunti, non solo utile come tassello di una storia della fotografia locale, ma anche come documento di una piccola città che si trasforma, vi sono altri nuclei di immagini di notevole interesse per un'analisi accurata dell'attività di Gildaldo Bassi. Importanti sono le piccole serie raffiguranti oggetti o opere d'arte, che spesso fungevano da corollario alle produzioni maggiori; è il caso delle riproduzioni di dipinti come per esempio il ritratto di Antonio Allegri, foto che mostrano l'insinuarsi di un'attenzione filologica nella costruzione dell'album, o per citare un altro esempio ancora, la fotografia di un simulacro in argento proveniente dalla chiesa di S. Francesco a Carpi, immagine legata alla serie religiosa sopra citata. Vari sono gli esempi che si potrebbero annoverare, nessuno di questi però contraddice la sua linea di fondo, che non si discosta dal gusto corrente del pubblico, accanto alle vedute mostra di gradire anche queste fotografie rievocanti alcune delle più interessanti ricchezze artistiche del paese. Più inusuali, perché proprio del personaggio Bassi, sono alcune immagini legate all'impegno politico, a quella sorta di "vangelizzazione" di cui si era fatto carico in ambito locale. Significative sono, soprattutto per la valenza documentaria, le immagini del Congresso Socialista di Reggio Emilia e del Banchetto nell'anniversario del giornale La Giustizia; legate invece a momenti di più diretta propaganda sono le tre fotografie scattate a San Martino in Rio, due delle quali relative all'inaugurazione della Cooperativa di Consumo (in cui è presente l'avvocato Curtini che tiene un comizio). Ricche di varie espressioni umane, dal politico gesticolante sulla folla, al ragazzino curioso in posa davanti all'obiettivo, nel complesso immagini fuori dagli schemi. Non si può dire certo la stessa cosa per la produzione ritrattistica dell'artista correggiese, che trova in precise regole il suo senso d'essere. Il ritratto, dalla nascita fino alla diffusione massiccia, trova una precisa e ben delineata precettistica a cui nessun atelier si può sottrarre, pena l'insuccesso commerciale. Questo coinvolge tutta la prassi lavorativa, dallo studio alle tecniche di ripresa.
Intorno agli anni settanta, in provincia di Reggio Emilia, sorgono i primi studi fotografici perfettamente attrezzati; sulla scia di questi, altri se ne impiantarono. Il Bassi fu uno tra i primi a lavorare fuori dalla città capoluogo; se in un primo tempo la sua camera oscura era allestita all'interno di un pittoresco carrozzone e lo studio sotto una particolare tenda mobile, che doveva richiamare in gran numero la popolazione dei piccoli centri rurali, dal 1880 anch'egli si dota dei più moderni ritrovati. Sopra la propria abitazione allestì una mansarda in gran parte coperta di cristalli, dotata di tende scorrevoli che permettevano la realizzazione di riprese fotografiche in qualunque stagione dell'anno e una sala di posa ricca di tutti gli strumenti del mestiere: dai pannelli riflettenti per proiettare la luce naturale su parti del volto, ai poggiatesta, che bloccavano il volto del cliente evitando spiacevoli effetti di mosso, dai fondali, dipinti con giardini dagli elementi neoclassicheggianti, alle immancabili colonnine, sedie o piccoli tavoli, pretesti per pose convenzionali. Un modesto salotto precedeva la sala di posa, un luogo per intrattenere i clienti, che divenne poi salotto politico, importante fucina per il nascente movimento socialista; qui, insieme ad altri attivisti, il Bassi organizzò le lotte di quegli anni; questo divenne inoltre biblioteca per raccogliere quelle pubblicazioni "indesiderate" dalla borghesia locale, ma necessarie alla classe contadina e operaia per prendere coscienza e ospitò addirittura la redazione di un piccolo giornale, La Fiaccola che il fotografo diresse per almeno un anno. Una vita molto vivace caratterizzò, in questi primi anni, l'attività dello studio correggese di cui possiamo raccogliere altre informazioni, più vicine all'interesse specifico della ricerca, nei versi (termine tecnico che indica il tetro) delle "carte de visite". Attraverso la raccolta e la disposizione cronologica di questi è stato possibile ricostruire importanti segmenti di storia dell'atelier: "Fotografia viaggiante" si legge sulle primissime fotografie, chiaramente riferite al periodo di "itinerante"; vere e proprie pubblicità recitano altri. "Si fanno ritratti a la Rembrandt, a la Walerè, trasparenti in vetri, in seta, di grandezza naturale, brillanti, di fantasia, uso comune, riproduzioni... si garantisce qualunque lavoro a perfezione ed a prezzi modici". Il correggese ebbe sempre cura di precisare questa caratteristica, grazie alla tecnica più veloce ed economica e a una particolare attenzione, visto il suo impegno politico, al sociale. L'elenco che precede, altro non è che una conferma di quanto già detto in precedenza: il ritratto è per gli ateliers di fine Ottocento un genere ben definito, ricco di schemi precisi e ben collaudati, che permettono un successo sicuro sul pubblico e di regole a cui neppure l'atelier di provincia del Bassi poteva sottrarsi. Ed ecco che il fotografo può ritrarre solo la testa o il busto, in piedi, di profilo, variando la provenienza della luce, che, se ad esempio proveniva da dietro illuminando la testa a tre quarti, dava l'effetto alla Rembrandt. il risultato: un vocabolario di pose stereotipate. Più diversificati i ritratti di bambini, "grande specialità" dello studio correggiese; molti fotografi si cimentavano proprio in questo settore, reso arduo per le difficoltà tecniche nell'immortalare il vivace soggetto. Comprensibili i problemi nel fotografare un piccolo che certo non ne voleva sapere di stare immobile per molti secondi, con risultati che si possono immaginare. Si va così dal fanciullo impacciato costretto in una posa adulta, al bambino sorridente, ma ahimè leggermente sfuocato! Piccoli e grandi gruppi, ripresi in studio o all'aperto concludono questa breve carrellata, con un'attenzione particolare per l'armonia e la forma nella disposizione.
   |