| Luciano Pantaleoni, Carla Pietri |
   |
| Le case contadine nella media pianura reggiana | |
| Correggio, identità e storia di una città |
| Luciano Pantaleoni, Carla Pietri |
   |
| Le case contadine nella media pianura reggiana | |
| Correggio, identità e storia di una città |
Attualmente non esiste uno studio approfondito sulle case rurali dell'area reggiana, né è mai stata affrontata in maniera completa una suddivisione tipologica di queste dimore.
Gli studi esistenti e la normativa attuale fanno sempre riferimento a due soli tipi di case: quello "bolognese", a corpi separati, in cui la stalla e l'abitazione civile sono distinte e quello a corpi congiunti, il cosiddetto tipo "reggiano", con la porta morta (nell'unico fabbricato è presente sia la stalla che l'abitazione del contadino).
Questa distinzione è giustissima ed è la più evidente ma ha un limite temporale e formale poiché all'interno di queste categorie esiste una casistica più vasta che si è venuta formando nel tempo attraverso evoluzioni successive e che si può peraltro facilmente percepire percorrendo le strade delle nostre campagne.
Si può affermare che esistono almeno sette o otto tipologie, tra loro distinte per forme, per usi e per destinazioni.
A questo punto occorre precisare che tale suddivisione va riferita al momento in cui queste tipologie sono arrivate a maturazione definendo una struttura organizzativa precisa.
Esistono poi due tipi di architetture rurali che è importante menzionare: il caseificio "casello"), che è sempre di proprietà padronale e nel quale la configurazione estetica diventa il mezzo di espressione di tale potere; e il "basso servizio" che al contrario non lascia spazio al superfluo, ma risponde pienamente alla concretezza del mondo rurale.
Le vecchie strutture si trovano però, nella quasi totalità dei casi, in un cattivissimo stato di conservazione dovuto al più completo abbandono. Il degrado sempre più devastante che ha colpito le vecchie abitazioni di campagna ha ormai tolto all'architettura rurale qualsiasi messaggio di vitalità.
Il desiderio del recupero di tali forme culturali sta proprio in questo: si sente l'esigenza di restituire vitalità a questa architettura: nel senso di capire l'importanza della cultura materiale appartenente a uomini che hanno agito e lavorato in epoche ormai lontane dalla nostra.
La casa del contadino riacquista vitalità proprio nel momento in cui riesce a dare stimoli che non siano solo nostalgici, ma in grado di suscitare il desiderio di voler conoscere e capire come era organizzato questo mondo, come funzionava, quali erano le sue tradizioni e i suoi modi di vita.
La "casa quadrata" riflette le esigenze della struttura economica della mezzadria nei secoli antecedenti la "rivoluzione agronomica". Era molto piccola, le varie attività domestiche erano svolte in pochi spazi, in ambienti ben definiti come ad esempio la cantina, il fienile, ecc ... La stalla di questo tipo di abitazioni era ridotta: due o tre "poste" e, in certi casi, lo stallino per il cavallo. In questa tipologia la parte rustica e la parte civile erano unite nello stesso fabbricato e gli accessi erano collocati in uno stesso portico esterno.
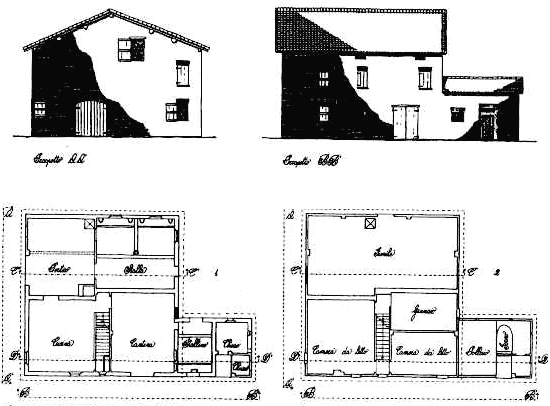
Molto avvicinabile alla tipologia quadrata è la "casa con l'andito" che possedeva all'interno della stessa fabbrica la parte rustica e la parte civile, mentre la parte abitativa veniva distinta con un ingresso specifico ai vari ambienti della casa.
Anche in questa tipologia ci troviamo di fronte ad un tipo di stalla dalle dimensioni ridotte: l'agricoltura era ancora basata su un modesto allevamento di bestiame.
La tipologia della casa con l'andito avrà una grossa fortuna nelle nostre campagne; l'andito, come fulcro distributore della dimora rurale, sarà presente anche nelle altre tipologie più complesse e posteriori a questa.
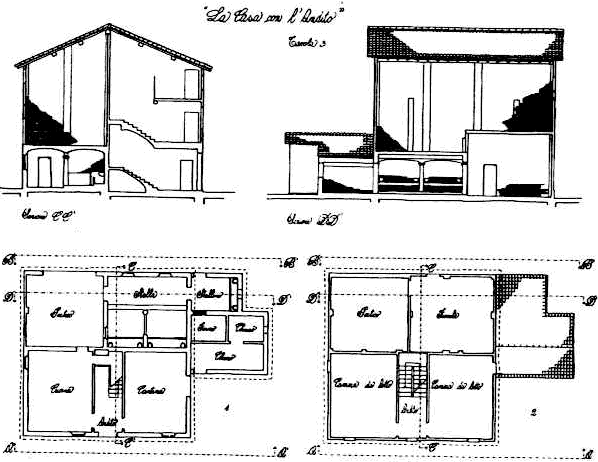
L'agricoltura reggiana, a partire dal XV sec., cominciava ad evolversi, la famiglia mezzadrile tendeva ad ingrossarsi sempre di più e di conseguenza la casa rurale subiva delle modificazioni. Le piccole case, che fino a questo momento rispondevano alle esigenze della famiglia contadina, si trasformarono disordinatamente, con tipologie non ben definibili e, in un certo qual modo, ibride (è necessario precisare che la suddivisione in tipologie è stata colta nel momento in cui queste sono arrivate a maturazione definendo una struttura organizzativa precisa).
Con la "rivoluzione agronomica" della seconda metà del sec. XVIII l'allevamento assunse un'importanza rilevante nel sistema produttivo avendo come conseguenza immediata la creazione di stalle più grandi. Spesso la trasformazione ha seguito questi passaggi: le piccole stalle delle case quadrate o con l'andito venivano trasformate in cantina e la stalla era ricostruita staccata dall'abitazione con sopra un fienile e con un porticato esterno per la conservazione del foraggio. Così nasceva la tipologia della "casa a corpi separati" con il fabbricato della stalla posteriore a quello dell'abitazione.
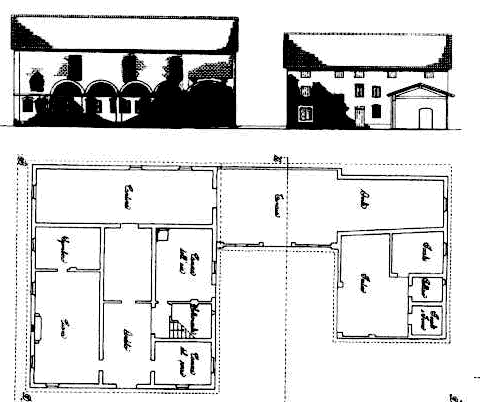
In questo periodo di grandi modificazioni va collocata la "casa completamente porticata" che costituì un esempio molto particolare per la realtà rurale reggiana.
Probabilmente questo tipo di casa era il frutto di una serie di elaborazioni successive, a metà tra la "casa a corpi separati" e la "casa con la porta morta" che vedremo in seguito.
Nella "casa porticata" la stalla e l'abitazione erano poste su una unica linea, con accessi distinti una dall'altra e si affacciavano ambedue sul lungo porticato.
L'ampiezza della stalla variava da una dimensione ridotta ad una molto più grande specchio di una mutata realtà economica.
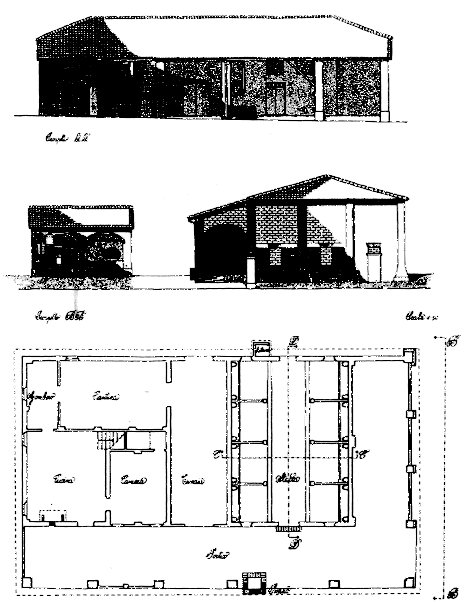
Attraverso le diverse esperienze nel campo dell'architettura rurale venne via via maturando un nuovo tipo di casa colonica di dimensioni più ridotte rispetto alla "casa a corpi separati", ma più comoda: la "casa con la porta morta", la più tipica casa rurale della campagna reggiano-modenese.
Essa prevedeva per i vari ambienti un'organizzazione molto semplice e funzionale. La parte rustica, contenente la stalla, il fienile ed ambienti di servizio, era unita all'abitazione con un lungo portico coperto, denominato "porta morta", perché in origine era chiuso al suo termine sul lato opposto.
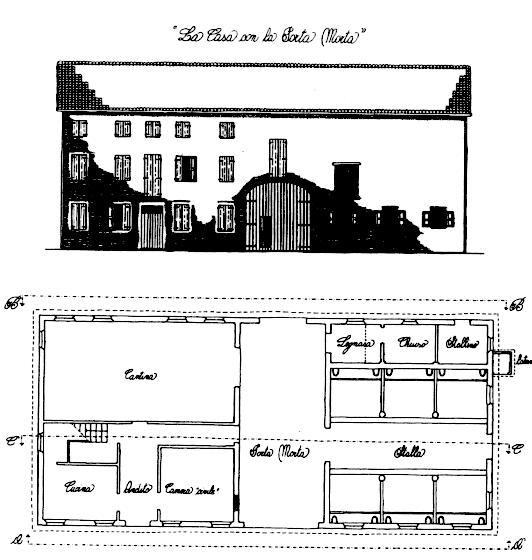
Un discorso a parte va fatto per la "casa bracciantile" e per il "casino padronale", anch'essi appartenenti alla classificazione delle sette tipologie di case rurali.
Nella struttura economica e sociale che la mezzadria era venuta creando, i braccianti rivestivano un ruolo particolare, in quanto svolgevano nelle campagne soltanto lavori stagionali e per il resto trovavano lavoro nelle prime rudimentali forme industriali delle fornaci, abbastanza frequenti nella nostra zona.
Gli esempi ancora esistenti sono rarissimi. Le "case bracciantili" sono state per lo più abbattute in quanto, con l'evolversi della società civile, si sono dimostrate completamente inadatte ad una qualsiasi opera di recupero o di trasformazione. Tale casa era di dimensioni modestissime: un ambiente al piano terra e uno al piano superiore; era collocata su piccoli fazzoletti di terra, molto spesso posti tra una via e un canale.
A volte grandi case ad andito davano alloggio a più braccianti.
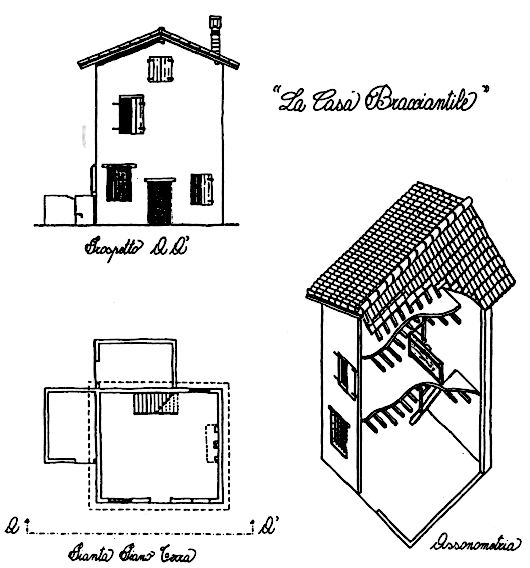
Contrapposto a questa casa poverissima era il "casino padronale".
Nella storia generale del paesaggio agrario italiano, ci sono stati due periodi di ritorno all'amore per la vita rustica: uno nel periodo rinascimentale e l'altro durante il Settecento, allorché acquistò sempre maggiore importanza la azienda signorile.
Nel reggiano l'azienda signorile era ripartita in diversi fondi su ognuno dei quali il padrone aveva installato una famiglia che provvedeva alla sua conduzione.
Su uno di questi fondi (di solito il più centrale o quello posto sulla via principale) il padrone costruiva un casino dove risiedeva in modo fisso o in alcuni periodi dell'anno sovrintendendo, in questo modo, alla sua proprietà.
Nelle campagne del Comune di Correggio, questi casini erano abbastanza numerosi. In alcuni casi avevano caratteristiche accentuatamente rurali, con grandi stalle e numerosi spazi per le attività agricole; altre volte si evidenziava ricercatezza stilistica nel complesso e nei particolari. La configurazione estetica diventò il mezzo di espressione del potere padronale.

Questo avvenne anche nell'architettura rurale del caseificio che era sempre di proprietà padronale e che in alcuni casi sorgeva accanto al casino. t interessante sottolineare il fatto che il latte, unico prodotto che non venisse diviso col padrone, era direttamente comprato da quest'ultimo, dato che rappresentava una produzione specialistica e molto redditizia.
La casa contadina fu lo specchio di una realtà completamente diversa, di un mondo duro che non lasciava spazio a ciò che era considerato superfluo. Ogni parte dell'abitazione che veniva costruita era l'esatta risposta ad una esigenza concreta e precisa; anche i "bassi servizi" erano caratteristici di tutte le case rurali.
Il "basso servizio" è una struttura indipendente dalla casa rurale e comprendeva tutti quegli ambienti utilizzati per scopi diversi come pollai, chiusi per l'allevamento dei maiali, forni, pozzi, spazi per deposito fascine, per la cottura del pane, ecc. ...
Di solito l'impostazione del "basso servizio" era questa: il forno centrale con sotto il chiuso del maiale e sopra il pollaio; anche in questo caso ci si trovava di fronte ad una soluzione che rispondeva ad una esigenza precisa: sia il maiale che le galline avevano bisogno di un ambiente caldo e asciutto.
Nel sistema economico instaurato dalla mezzadria, il padrone "tollerava" che il contadino si dedicasse a delle colture e ad allevamenti particolari che non rientravano nel novero dei beni da dividersi a metà; nei contratti venivano chiamati "appendici", con la specificazione del numero di uova, galline, conigli, ecc., che il contadino doveva al padrone in un anno.
La costruzione del "basso servizio" era soggetta al permesso del padrone il quale lasciava al contadino l'incarico della sua realizzazione. Forse sta
proprio in questo fatto la bellezza di queste piccole architetture: ogni contadino lo personalizzava moltissimo dando vita a forme e a disposizioni svariate.
Col passare del tempo questa struttura poteva subire degli ampliamenti di portichetti, di spazi nuovi per allevamenti particolari dettati da esigenze diverse.
Anche nella scelta della collocazione del "basso servizio" il contadino era guidato da motivazioni ben precise. Questa struttura di servizio non era mai relegata dietro l'abitazione; il contadino aveva un'esigenza di controllo continuo, dei pochi beni che possedeva.
Un altro motivo, certamente meno concreto, ma senza dubbio più romantico, potrebbe essere costituito dal fatto che la collocazione del "basso servizio" davanti alla abitazione e vicino alla strada costituiva la possibilità di maggiori occasioni di incontro con la gente che passava mentre ci si recava a dar da mangiare ai maiali o si aspettava che cuocesse il pane.
   |